Il tramonto di DeviantArt e l’alba dell’anima digitale
Nostalgia queer vs etica dell’Intelligenza Artificiale.
CULTURA DIGITALE
by Martin J. Osburton
8/18/20253 min leggere
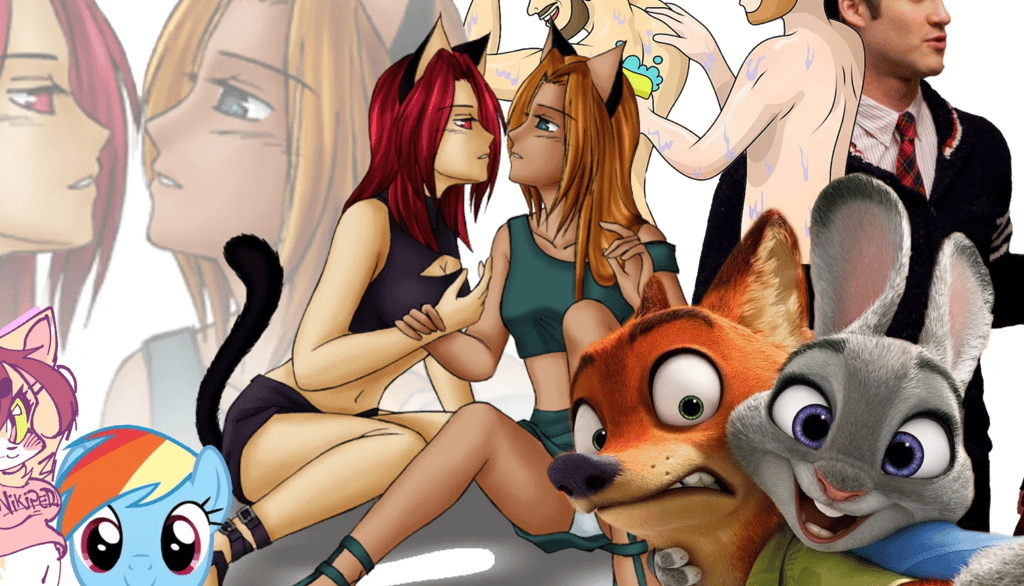
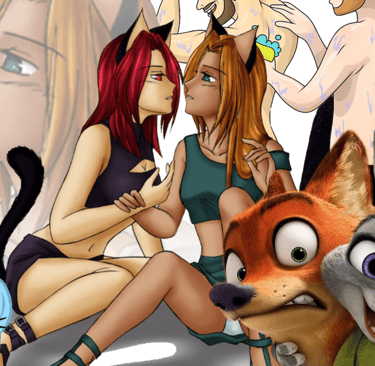
Wikimedia Commons/Collage by Yoo Bee
Venticinque anni fa DeviantArt ha dato una casa a chi cercava uno spazio per disegnare sé stesso — e l’altro — senza giurie né guardiani. Oggi quell’archivio condiviso vacilla: IA generativa, nuovi filtri d’accesso, metriche aziendali che premiano “quanto” usi l’IA. Non è solo una storia di piattaforme. È la domanda di fondo: che cos’è ancora umano, online?
DeviantArt: un archivio queer (non un sito qualunque). Il 7 agosto 2025 la piattaforma ha festeggiato 25 anni. Per un quarto di secolo è stata un cartografo delle minoranze creative: fandom, shipping, furry, erotismo consenziente, apprendistati veloci e legami duraturi. Un museo dove l’arte restava rintracciabile sul lungo periodo, non risucchiata dall’algoritmo del giorno dopo. È un dato culturale, non un vezzo: secondo Pew Research, una quota enorme del web sparisce nel tempo (il 38% delle pagine del 2013 non è più accessibile), ma su DeviantArt molti contenuti di vent’anni fa sono ancora lì, vivi.
Poi è cambiato tutto: nel 2022 DeviantArt ha abbracciato l’AI art (DreamUp), tra opt‑out/opt‑in e un’ondata di backlash. Il risultato? Un “flood” di immagini generate che ha reso più difficile emergere agli artisti NSFW che vivevano di commissioni, mentre parte della comunità migrava verso Telegram, Bluesky, Pixiv.
Età, filtri, cancellazioni: l’effetto “igiene” del nuovo web. Al quadro si sommano i nuovi doveri di age‑assurance: nel Regno Unito, dal 25 luglio 2025, i servizi che ospitano contenuti pornografici devono applicare verifiche d’età robuste (Ofcom). Anche piattaforme con “mature content” hanno stretto i filtri e irrigidito le policy: non tutto è censura, ma la direzione è chiara — spazi protetti, sì, ma più chiusi. Per gli artisti queer e NSFW, l’attrito aumenta; la soglia d’ingresso sale.
Qui la nostalgia non è romanticismo, è memoria politica. DeviantArt non era solo arte; era documento collettivo: corpi disegnati, desideri, provini d’identità. Convertire quell’archivio in un catalogo sterile, filtrato da norme e da prompt che clonano stili, significa perdere — almeno in parte — l’anima digitale della comunità.
L’IA come filtro culturale (non solo come motore). C’è chi dice: “Siamo già in Her?” Non proprio. L’IA modellerà i prossimi 25 anni, ma l’impatto culturale pieno deve ancora arrivare. Nel frattempo, però, sappiamo che il mercato dell’IA potrebbe raggiungere 4,8 trilioni di dollari entro il 2033 (stima UNCTAD), e che la quotidianità è già piena di chatbot, deepfake, affetti delegati. Tradotto: l’IA non è solo un acceleratore tecnico; è un filtro che ridefinisce desiderio, relazione, attenzione.
La domanda creativa è spiazzante: se posso ottenere la mia “coppia del cuore” in cento varianti con un prompt, che ne è del tempo lento del desiderio, della frizione con l’altro, dell’errore che fa stile? Il rischio non è l’IA in sé, ma la deriva estetica verso un infinito di immagini “sufficienti” che saturano il bisogno prima ancora che nasca.
Dal feed allo stipendio: quando l’algoritmo valuta l’umano. Fuori dalle community, nelle aziende: il CEO di GitHub, Thomas Dohmke, ha definito “totally fair game” chiedere ai manager di valutare le persone anche in base a come usano gli strumenti d’IA (Copilot e affini). Non linee di codice “generate”, ma mentalità di apprendimento, dice. Pochi giorni dopo ha annunciato che lascerà il ruolo a fine 2025 (annunciato l’11 agosto), restando nel perimetro CoreAI di Microsoft: segno che l’IA non è un tool ma è ambiente.
Qui l’analogia con DeviantArt è beffarda: se il valore umano diventa “quanto usi l’IA”, non “cosa inventi con altri”, l’ironia si assottiglia, e con lei la curiosità. La creatività — queer, aziendale, scolastica — rischia di slittare dal laboratorio alla dashboard.
Che cosa salviamo, davvero? Tre coordinate per non perdere la bussola: Archivi vivi: trattare DeviantArt come un patrimonio (con snapshot, export comunitari, licenze chiare). Il web dimentica in fretta: un quarto delle pagine 2013‑2023 è già svanito. Etica d’uso: non demonizzare l’IA, ma chiedere trasparenza sui dataset, segnaletica sui contenuti generati, priorità al lavoro umano quando conta (commissioni, crediti, revenue‑share). Valutare la relazione, non il contatore: nel lavoro, premiare esiti e collaborazione; l’IA come protesi cognitiva, non come metrica identitaria.
Questa non è solo nostalgia. È una richiesta semplice: che l’arte digitale non perda anima nel feed. Perché se una creazione queer viene rimpiazzata da un prompt, avremo vinto la tecnologia — sì — ma perso qualcosa di vivo. Vale davvero la pena?
Riflessioni
Uno spazio per pensare oltre la superficie.
Creatività
martin@osburton.com
+?? ??? ??????? - vuoi sapere il mio numero di telefono ? Clicca qui.
© 2025. Tutti i diritti sono riservati.
